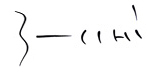2023 – Volumi – GALLERIA GABURRO – Milano
Il suono della pittura
1. Rime, ritmi
L’opera di Danilo Bucchi, apparentemente semplice nella sua immediatezza, ci pone tuttavia di fronte a complessi problemi concettuali. Innanzitutto, di fronte a una difficile domanda: come far sentire la pittura oltre i rigorosi modelli del visibile e permettere che, allo stesso tempo, la si possa ugualmente avvicinare alla percezione del suo volume andando incontro a una dimensione tattile, quasi scultorea, ma anche alla nostra memoria della musica e del ritmo, cercando in essa un’esperienza di ordine musicale?
Infatti, nelle sue molteplici espressioni — installazione, fotografia, pittura o anche nei lavori di carattere digitale — l’artista ritorna sempre in una modalità che possiamo designare come di natura ritmica, che ci permette di percepire la sua intensa relazione con una notazione di carattere musicale. È così che ogni gesto, ogni segno, ogni movimento del corpo — perché è di registri del corpo che di fatto parliamo — che si proietta sulle superfici e che troviamo costantemente nel suo lavoro, si segnala come forma di una gestualità vicina all’improvvisazione, alla notazione musicale e persino alla poesia concreta, che rivela, contemporaneamente alla capacità di muoversi verso i giochi del caso di John Cage, un forte indice performativo: come, a questo proposito, ha detto Achille Bonito Oliva “Oltre ci sono gli imprevisti della vita e le forme nella sua creatività”.
Così, quello che percepiamo subito al primo contatto che abbiamo con la sua opera ci rimanda invariabilmente a un senso percettivo che, attraverso il nostro corpo, comprendiamo essere anche originario dal movimento di un altro corpo, funzionando quasi come in una dimensione performativa. Infatti, il lavoro dell’Artista, la sua gestualità elegante e sottile, che ci sembra quasi equivalente a una modalità di scrittura — il che, su un piano erudito, evoca Cy Twombly ma anche Henri Michaux e che ugualmente dialoga, a un altro livello, con gli stessi graffiti che inondano le strade delle nostre città — presuppone, nella sua esecuzione, un movimento performativo del corpo e una forte iscrizione del gesto nel dipinto, che tende a renderlo immediatamente dell’ordine dell’avvenimento.
Perché in realtà, questa gestualità, per quanto discreta e quasi capricciosa ci sembri, con la sua strutturazione di spazi il cui carattere è, per così dire, barocco, implica un avvicinamento allo spazio della pittura che richiede al corpo di compiere una gestualità propria, nell’improvvisazione, capace di un movimento d’iscrizione che, come Bonito Oliva aveva così ben compreso, lo trasporti fino a una dimensione che è, prima di tutto, vitale. Ma determina anche, nella sua comunicazione, una presenza quasi invisibile, tuttavia sensibile, di un’economia di ritmi e rime che costantemente conducono le forme del disegno fuori da loro stesse, generando uno spazio ambiguo poiché popolato da una specie di calligrafia febbrile.
Una pratica di ordine poetico che in verità avvicina il suo lavoro, sebbene in modo lontano, a quella grande tradizione di automatismo che, da Mirò a Pollock o da Henri Michaux a Jean Dubuffet e più tardi ad Alechinski, ha definito una nuova forma di relazione tra immagine e segno, tra pittura e scrittura, relazione potente fondata sulla nozione di ritmo che il XX secolo ha costantemente reintegrato, comprendendo la necessità di tornare alla fonte arcaica, quando non al riferimento geroglifico.
2. Il momento egizio
È stato il filosofo italiano Mario Perniola a insistere già sulla possibilità di un effetto e anche di un momento egizio nell’arte e nella società, per cercare di spiegare in questo modo alcuni segni tipici della contemporaneità rilevando, attraverso tale designazione, la presenza simultanea di più temporalità coabitanti nel tempo attuale, cosa che il filosofo considerava essere ugualmente una caratteristica della cultura arcaica egizia: “Se tutto può essere arretrato, nulla è attuale, e allo stesso modo tutto è repertorio, perché tutto può diventare immediatamente presente ”.
Così possiamo dire che l’opera di Bucchi inscrive qualcosa che è dell’ordine di un momento egizio poiché in esso misteriosamente convergono presenze che non solo la collegano al suo stesso tempo — in particolare nei modi in cui assume il rapporto con la fotografia, i linguaggi dell’installazione o anche le intensità del digitale — ma ugualmente dialogano con numerose altre fonti visive.
È in questo modo che le sue opere si legano sottilmente a innumerevoli artisti di vari secoli prima del nostro, attuale: come accennato in precedenza, dall’arte barocca al XX secolo, i collegamenti sono molteplici poiché la sua opera mantiene relazioni inaspettate con Pollock, con Saura, Michaux, Dubuffet o perfino con il graffitismo urbano attuale.
Perché, però, citare qui il barocco? Se prestiamo un po’ di attenzione alla sua modalità di costruzione interna, vediamo subito che l’opera di Bucchi inscrive costantemente queste variazioni, quasi come filigrane, in cui la linea si sviluppa come se danzasse nello spazio totale di cui dispone. E se secondo Wolfflin, la linea era più un segno tipico del classicismo che del barocco, essendo questo risultante dalla macchia, il fatto è che in queste numerose linee che si muovono incessantemente nel suo lavoro, in una gestualità che esita tra la figura e l’astrazione più pura, l’artista fa apparire la suggestione della macchia, dall’impulso nervoso di questo movimento. Non tanto perché cerca la macchia, ma questa si fa presente, sebbene costantemente esitante tra i neri e i bianchi.
Barocco è, quindi, questo scintillio nervoso, urgente, che la mano applica intensamente sulla superficie, come se cercasse la saturazione, così come quella dimensione quasi scultorea che scatena gradualmente, vibrando nei molteplici spazi che genera e che, come le pieghe di Leibniz, ci trasporta in un universo di sensibilità artificiosa. Nello stesso modo in cui il colore acquisisce il suo spessore, lascia indovinare la possibilità di un inconscio scultoreo che percorre dall’interno tutta la sua pittura, come se si legasse tutta tra sé, attraverso questi diagrammi fatti di nodi borromei (di cui Lacan ci ha parlato), che sottolineano la dimensione inconscia che di fatto sembra abitarla.
3. L’immagine della moltitudine
Se, a prima vista, la fluidità delle linee è organizzata come uno spartito musicale e la sua notazione sulla superficie del dipinto suggerisce una scrittura animata di segni apparentemente destinati a essere tradotti in suoni, subito dopo suggerisce la presenza animata di figure, numerose figure che si direbbero nate da un graffito di strada in una delle nostre città, suggestioni di una folla che, come nei manifesti politici, fa sorgere davanti ai nostri occhi quello che riconosciamo come immagine della moltitudine. In tal senso questa è un’arte intensamente urbana, contemporanea, vibrante, suggestiva, animata da questa sottile tensione geroglifica che nell’immediato non sappiamo come decodificare, poiché attraverso di essa appare una trama intensa, indecifrabile e persino frattale.
Così come accade di fronte ai drippings di Pollock potremmo dire, di fronte a questi movimenti di colore e dei gesti che li animano, che essi corrispondano a impulsi che riverberano grazie alla presenza immediata di quello stesso gesto, le intensità di danza di un corpo. Quasi convulsive, poi, come conseguenti all’urgenza del performer che, sulla tela in bianco — lo schermo — lascia svilupparsi trame complesse, movimenti impulsivi, sismografici, di una rivisitazione attuale dell’action painting, cercando di fissare, in questa velocità impetuosa, una specie di movimento automatico della sensazione.
Tuttavia, subito dopo, e grazie alla nostra abitudine di vedere e osservare, capiamo che queste forme micro-gestuali sono anche delicate suggestioni figurali, che evocano la complessa trama delle figurazioni dense di António Saura, il grande artista spagnolo le cui figure arrivano da una notte abitata dai fantasmi della danza — del cante jondo e del flamenco — i cui movimenti contratti tornano in scena in figurazioni dal senso quasi drammatico. Ma questo movimento della linea, subito dopo, suggerisce un collegamento remoto con il gesto interrompente di Burri, o con le linee strappate sulla tela da Lucio Fontana.
Nel suo momento egizio, queste di fatto convocano moltitudini, ma davvero, moltitudini di figure provenienti da riferimenti multipli, eruditi e popolari, che potremmo giudicare distanti tra di loro ma che, tuttavia, evidenziano la capacità, nello stesso volteggiare della linea, di chiamare a sé i ricordi di Clifford Still, così come il nervoso registro della linea arcaica sui muri, che ci ha insegnato la fluente pittura di Cy Twombly.
Tutto, infatti, nell’opera di Danilo Bucchi è allo stesso tempo registro automatico e impetuoso di un’enigmatica “conoscenza dagli abissi” — quella connaissance par les gouffres di cui parlava Henri Michaux — forma animata di quello che potremmo designare come vestigio di una gestualità danzante, senza pretese e dal carattere per così dire nietzschiano, dal momento che sembra essere tutta costruita come memoria di una danza dello spirito stesso o, più semplicemente, come un movimento liberatorio della mano su un muro. Analoga, quindi, a quell’altra che il giovane graffiter che cammina nella notte delle nostre città lascia inscritte, come segno di vita o come traccia per tutti coloro che passano davanti ai muri che nascondono le case.
Arte di strada e arte erudita, quella di Danilo Bucchi cammina tra registri che misteriosamente collega e abbraccia in un’unica capacità di fissare come impetuosi registri compositori, concreti, della vita stessa: in questo senso la sua è un’arte poetica, più che un’arte di pittura, poiché in molti aspetti ci sembra che l’ordine della poesia preceda l’ordine dell’immagine.
4. L’impero dei segni
È in questo incrocio che forse troveremo la chiave più esatta per l’enigmatico universo plastico di Danilo: tra poesia e pittura, tra scultura e gesto, tra segno e simbolo, la sua arte accenna, da lontano, a un altro campo che forse ci è meno evidente: l’immagine fotografica, pratica che ha ugualmente sviluppato.
In una serie che ha realizzato, Japan Diary e che rimane inedita, l’Artista ha chiarito i suoi processi e possiamo quindi capire in cosa consiste ciò che, secondo Deleuze, potrebbe essere designato come la sua formula, ovvero, in un registro sintetico, esattamente diagrammatico, in cui l’immagine fotografica innesca un’idea dello spazio urbano che poi riemerge nella sua pittura come già sintetizzato. Infatti, nella sua opera plastica, Danilo Bucchi cerca di formulare immagini sintetiche capaci di comunicarci intensità, impulsi, segnali di carattere quasi grafico, di ciò che è la scrittura della vita nelle città, che lui capta alla maniera del flanêur baudelaireano.
La visione della città appare come sintetizzata, o meglio, diagrammata, come se partisse dalla condizione di essere solo un foglio bianco su cui una varietà di segni multipli e chiusi potrebbe essere inscritta: tutto sembra organizzarsi nelle strade, nelle piazze, negli spazi pubblici, che siano edifici o muri, viali o giardini, come se obbedissero a una stessa logica impulsiva nata dal movimento stesso della vita, scrivendo se stessi sullo spazio urbano.
I suoi riferimenti pittorici, che ho menzionato sopra, gli servono non tanto come modo per incorporare citazioni erudite, ma piuttosto come elementi che gli consentono di accedere alla costruzione di un linguaggio proprio, quasi un alfabeto, suscettibile di trascrivere, in una scrittura veloce, vibrante, elegante, urgente e intensiva, una visione del mondo.
Infatti, la sua dimensione geroglifica — alla quale ho accennato prima — acquisisce forza ai nostri occhi, così ci rendiamo conto che, grazie a essa, siamo portati a presenziare, come davanti a un grande schermo, a un’esperienza analoga a quella che ci offre essere in possesso di una forma di scrittura.
Così, come nel carattere giapponese, il cui significato è allo stesso tempo grafico, visivo e sintagmatico, anche qui si direbbe che, quasi alla maniera del grande Saul Steinberg, tutto è organizzato secondo una logica pittorica fluente e per alcuni aspetti simile a quello che presiede la costruzione dell’incisione giapponese di Ukiyo-e.
Ma, nell’opera di Danilo, queste immagini che evocano il carattere orientale, acquisiscono ora una dimensione scultorea. L’artista ha scelto di passarli a una tridimensionalità attraverso ritagli operati su legno che poi dipinge e che può montare direttamente sulla parete, dove ogni figura riappare come su un pannello dipinto. Figure libere nello spazio, che transitano dal disegno e dalla pittura per entrare nella dimensione scultorea, servono ora a riattivare il senso musicale dell’intera opera, a cui ho accennato sopra. Generando una specie di danza, popolando le pareti in cui si accoglie la sua esposizione, sono figure vive di questo movimento che lega l’opera di Danilo Bucchi a un nuovo sentimento che si potrebbe definire da orientalista. Tutto acquisisce la dimensione del movimento, della fluttuazione, della dinamica dei segni quando sono liberati dal significato immediato e consegnati solo alla variabilità del suo essere-segno.
Geroglifici, saltano dai dipinti per invadere i muri, come graffiti per le strade delle nostre città, animati quasi da una vita propria e poetica, creature di sogno e di fantasia che danzano liberamente negli spazi e che alludono a un tempo mobile, che evoca questa modernità liquida di cui ci parla Zygmunt Bauman e nel cui regime tutti ci imbattiamo in una realtà commovente, mai fissa, fluente e segnata dalla dissoluzione della precedente immagine che avevamo del mondo come un solido.
Così qui ritroveremo i ritmi sensibili di questi “ritratti del mondo fluttuante” che hanno fatto la gloria dell’arte giapponese a partire dal XVII secolo, le cui intense rappresentazioni della vita urbana avrebbero segnato, due secoli dopo e in maniera indelebile l’arte dell’occidente a partire da Manet, generando nuove e inaspettate forme di rappresentazione che hanno portato alla nascita della Modernità.
Tutto qui è mobile, intenso, allo stesso tempo sismico e segnico, suggerendo un’apprensione della vita analoga a quella che Roland Barthes ha appreso in Oriente e che poi ha chiamato l’impero dei segni proprio per designare questa coincidenza estrema tra vita e linguaggio che gli sembrava differenziare la cultura orientale da quella occidentale.
La pittura di Danilo Bucchi è un cinema: di fronte a lei, dobbiamo solo lasciarci trasportare dalla sua intensa narrazione, per la fluidità dei suoi gesti, segni, note, per il modo in cui, vibrante, trascrive in una scrittura tutta sua, il nuovo ordine poetico che attraversa il nostro tempo.
Bernardo Pinto de Almeida
Marzo, 2023