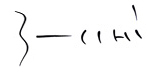2012 – Danilo Bucchi – PALAZZO COLLICOLA – Spoleto
PALAZZO COLLICOLA ARTI VISIVE
Danilo Bucchi (20 Novembre 2011 – 26 Febbraio 2012)
a cura di Gianluca Marziani
PUNTO. LINEA. CERCHIO
Gianluca Marziani
Punto, linea, cerchio: le fondamenta del disegno stanno qui. Dalle grotte di Lascaux alla scrittura di Cy Twombly, dai ritrovamenti rupestri al writing evoluto, da Giotto agli artisti che oggi privilegiano l’essenza dentro l’innovazione, il perimetro dell’esercizio primario (disegnare) si racchiude nei tre passaggi con cui la vibrazione mentale (ideare) crea visioni bidimensionali. Sul filo dei cambiamenti recenti, disegno e pittura sembrano appartenersi con la stessa fluidità che collega i fiumi al mare: il disegno indica la matrice, l’idea diretta ed essenziale che defluisce verso margini aperti; la pittura mette il sangue in azione, creando la circolarità interiore del disegnare, un moto biologico che amplifica le esigenze endogene dell’idea. Non ci sono più distanze, semmai si deve parlare di appartenenze. Ancor più nette davanti al potere demiurgico del digitale, così integrato alle linee essenziali del disegno a mano, così “post” per natura, così vicino al nucleo di ogni forma. Gli opposti (manualità ed elettronica) confluiscono oggi in un limbo che elimina l’ideologia linguistica, riportando l’attenzione sui veri contenuti dentro la fluidità estetica. Ed ecco la manualità ritrovare gli echi ibridi dei talenti cosmogonici, in particolare Joseph Beuys a Mario Merz che hanno nobilitato la carta con il sangue della pittura e la tela con l’ossigeno del disegno. Lo scambio dei codici è il segno di un futuro col tempo presente.
Velocità, sintesi, controllo: tre momenti che delineano l’attitudine del gesto, la natura del segno e l’impostazione visuale dell’artista. Significativo, in particolare, il connubio tra processo cerebrale ed esecuzione tecnica: esiste un flusso senza interruzioni tra l’idea e il suo sviluppo sul quadro, giocato su un automatismo concentrico che evita la frammentazione discontinua del pennellare. L’uso della siringa al posto del pennello rende possibile la fluidità motoria del gesto veloce eppure calibrato, un’azione che risente delle energie Gutai (l’avanguardia giapponese che aprì la tela alla forza muscolare dell’agonismo) ma anche di Jean Dubuffet e Wols, Jackson Pollock e Maria Lai, fino alla cultura street di cui Bucchi sembra un fuoriuscito talentoso e inclassificabile. Le diverse influenze si raccolgono assieme per una formula che è un codice linguistico, imprinting lessicale con cui l’artista trasforma quei corpi mentali in un “mondo alla Bucchi”.
Il cerchio nero di Bucchi è un modulo costruttivo, un mattone senza spigoli che edifica storie umane dentro il teatro bianco della superficie. La rotazione segnica diventa un intrico di figura, massa e racconto, una sorta di perimetro organico che sviluppa la fisicità in “negativo” attraverso il bianco piatto del fondale. I vuoti si riempiono attraverso la sottile linea nera dello spruzzo, mentre il rosso spunta (solo in alcune opere) tra pieghe e angolazioni, su interstizi che confermano lo scorrimento di una linfa ematica, vero e proprio ossigeno che scalda il segno nero e il bianco degli organi caldi. Trovo conferma a quel pensiero biologico che collega disegno e pittura, mi azzarderei a dire che Bucchi sta varcando una soglia su cui occorre riflettere in termini generali. Parlo del limite linguistico che ha sempre diviso carta e tela, matita e pennello, foglio e telaio. Quel divario storico (disegno come bozzetto e prodromo, pittura come esecuzione e definizione) perde ragion d’essere in virtù della filiera elettronica al centro del nostro bioritmo. La tecnologia digitale ha spezzato il duopolio bozzetto/esecuzione, assorbendo il filo dei linguaggi storici ma filtrando tutto nei materiali che compongono la tecnologia stessa: gli strumenti simili eppure diversi, i colori del monitor che sono altra cosa dai colori ad olio o acrilico, i supporti di stampa che assorbono in una certa maniera gli inchiostri, le visualizzazioni che lasciano un filtro (il monitor) tra l’occhio e la forma creata, queste ed altre identità stanno cambiando percezione ed esecuzione, creando un metalinguaggio che non si preoccupa più di alcuna divisione dogmatica. Non dimentichiamo che il linguaggio digitale fonde assieme l’essenza della linea (la scuola Apple di Steve Jobs agisce da sempre per sottrazione e sintesi) con la pluralità del barocchismo (il percorso storico della grafica digitale parla di accumuli e virtuosismi), creando quel metalinguaggio che concepisce modelli unici ma non univoci, liberi di spaziare ma delineati per struttura generale. Non pensiate che il linguaggio elettronico sia una porta anarchica dove tutto è permesso. Le regole esistono e costituiscono la massa critica, un’ideale costituzione che indica e denota, permette e vincola. Il gioco attuale riguarda minimi equilibri tra addizioni e sottrazioni. Il nuovo millennio è una bilancia che plasma le sue tarature sul momento storico e sul contesto specifico, dando al metalinguaggio una centralità che sta riscrivendo le regole dell’arte.
Il cerchio è la figura primaria del dipingere infantile ma anche delle evoluzioni giottesche, delle astrazioni di Paul Klee e Vassily Kandinsky, del poverismo installativo di Gilberto Zorio ed Eliseo Mattiacci… potremmo andare avanti e indietro nella storia artistica, trovando richiami che aumentano l’interesse verso il cerchio come “mattone elaborativo”. Un processo di sintesi profonda che ricorda, per grammatica e modelli esecutivi, il principio di certa musica elettronica, quella di scuola Warp o Minus per capirci. Bucchi crea pittura fisica dal “suono” sintetico: matrice iniziale, ripetizione senza meccanicismo, pulizia del perimetro (il singolo suono digitale) e galleggiamento su fondali neutri (ciò che accade nella qualità cosmogonica di un brano elettronico). Non è un caso il legame che Bucchi sviluppa tra esecuzione e performance sonora, momento di quadratura del cerchio ambientale, un passaggio che espande il gesto allo spazio plastico dei luoghi fisici. E non è un caso che ogni opera ragioni su ideali pentagrammi figurativi, seguendo griglie invisibili in cui le figure dialogano, si toccano e sovrappongono, sempre nel circuito virtuoso del bianco come geografia cerebrale. Carta o tela si trasformano in un laboratorio liberatorio che autorizza alterità e cortocircuiti, a misura di ogni singola azione creativa.
Sento Mario Schifano, maestro italiano di un dipingere che era pura libertà tra gesto e colore, artista che raccontava l’apparenza dell’ovvio e rendeva il banale un solco profondo. Sento la gestualità ritmica di Cy Twombly e Sol LeWitt, due asceti del segno cardiaco, due monaci creativi che mettevano la biologia motoria dentro il controllo tra corpo e spirito. Sento il brutalismo poetico di Jean Dubuffet, il suo agonismo materico ed entropico. Sento gli automatismi caldi di Andrè Masson, le crittografie incisive di Wols, lo sgocciolamento ritmico di Jackson Pollock, grandi maestri di istinti profondi, codificatori di nuove astrazioni, visionari cosmogonici in cerca di galassie interiori. Sento la potenza metallica del writing di Futura 2000 e Rammellzee, le loro scritture metatribali e i loro cybergrammi ipnotici, a metà tra il segno assiro e l’alfabeto che non ancora non c’è…
Vedo il colore nero allargarsi o stringersi, compattarsi o lasciare zone morbide: un modo per tornare al fattore terapeutico dell’arte come esercizio interiore, sistema di ordine e richiamo vigile, momento di velocità controllata e controllo veloce. Vedo la sintesi che si trasforma in reinvenzione del mondo attraverso la semplicità del tratto primordiale. Vedo uomini neri che non fanno paura ma incutono riflessioni. Vedo un bianco dei fondali che è il nuovo nero dell’oscurità rivelata. Vedo nel segno l’anima di un occhio speciale…
Sentire la memoria storica come fattore di incidenza elaborativa
Vedere lo stato fisico dei quadri come sintesi di una memoria metabolica
Sentire e vedere come stati per capire lo spirito del segno infinito
Le opere finora prodotte impongono alcuni pensieri riepilogativi. Il filo della coerenza si dipana senza interruzioni, e su questo credo rispondano le cose dette finora. Semmai dobbiamo individuare alcuni passaggi da un soggetto pittorico all’altro, sempre dentro la visione espansa del corpo elastico, principale e massivo interesse per Bucchi. Il termine “elastico” indica un corpo mutevole che segue le indicazioni ispirative e visionarie, un corpo che somatizza le attitudini, la memoria e la coscienza dell’artista. Si tratta di forme espanse o compresse, ricche o povere di dettagli, espressive o indefinite, armoniose o disarticolate… nessun limite tematico o contestuale tra i corpi dei vari cicli, semmai assistiamo alle variazioni indipendenti di un corpo-matrice (l’artista stesso) che metabolizza corpi-alias e li aggrega in maniera simile ma ogni volta diversa.
Ogni ciclo un’idea del corpo umanizzato
Ogni corpo un’azione sul quadro
Ogni ciclo una storia per frammenti autonomi
Il quadro diventa una narrazione liquida, priva di testi ma non di sottotracce che aprono varchi interiori. Bucchi dipinge con le regole aperte del flusso interiore, ricapitolando l’istinto nei margini domabili della ragione. Il suo moto è catartico, una pressione verso l’esterno che esplode in circonferenze d’inchiostro. C’è qualcosa di orchestrale nelle folle o nei gruppi dipinti, una strana coincidenza con la cultura del social network e del web in generale, spazi centrali nella visione liquida del presente. Non vedrete nulla di esplicito in tal senso, il paesaggio umano di Bucchi vive di manualismi meccanici (la siringa crea ritmo, pausa, velocità) e vibrazioni elettriche. Il senso del network riguarda le armonie apparenti della massa dipinta, il rapporto tra pieni e vuoti, l’omogeneità tra campo lungo e piano ravvicinato. E’ come se tutti parlassero una lingua comune (il linguaggio informatico) e galleggiassero nel medesimo contesto (nel web riguarda Facebook, Twitter, Linkedin, Tumblr…), annullando le differenze nell’apparenza dell’identità virtuale. Si diffonde un’entropia che mantiene ordine e relazioni, un dialogo esteso che travalica il singolo quadro e rende l’artista un quaderno aperto di appunti mentali.
Nei margini dialettici tra liquido e solido, ripenso ai film “Tron” e “Tron Legacy”, così virtuali nel loro perfezionismo geometrico, un tocco da Leni Riefenstahl digitale dove vincono gli spigoli in un effluvio di luce al neon che disegna superfici tramite forme perimetrali. Bucchi ragiona al contrario e ribalta gli angoli retti in flussi circolari, anche lui definendo le superfici attraverso lo spessore del perimetro. Come dicevo prima, la narrazione dei soggetti è liquida e defluisce verso gli spazi intimi della geografia privata. Il segno vibra di correnti gravitazionali, segue il ritmo interiore come un elettrocardiogramma sfrenato. Il mondo di Bucchi somiglia alle veggenze liberatorie del protagonista di “Tron Legacy” (interpretato da Jeff Bridges), quel Kevin Flynn che plasma un mondo parallelo sulla base neutra di una pura visione privata. Forma e contenuto dei due film si fondono assieme nel cortocircuito risolto tra reale e virtuale; qualcosa di simile accade al nostro Bucchi nel suo cortocircuito complesso tra linguaggi, generi e stili.
Danilo Bucchi non ha alcun legame con l’illustrazione e il fumetto. Chiudo il testo con questa negazione che diventa affermazione identitaria, così da evitare il fraintendimento formale della somiglianza. Lo dico senza togliere nulla all’autonomia espressiva di illustratori e fumettisti, al contrario vorrei che ogni linguaggio venisse esaltato nella sua altezza e nelle eventuali relazioni dialogiche con altri codici. Esistono artisti come Raymond Pettibon in cui fumetto e pittura ragionano per assonanze, ribadendo la coincidenza storica tra carta e tela. In altri casi, e Bucchi è uno di questi, il segno espressivo richiama gli elementi sintetici dell’illustrazione ma con codici chiaramente pittorici, blindandosi nel flusso mnemonico del puro richiamo artistico. Per capirci con un esempio, il codice è sintetico come nel fumetto ma il primo rimando vola verso Pollock o Dubuffet. Questo significa che l’artista si mimetizza dentro uno stile per farlo proprio, codificandolo come grammatica e sintassi. Uno stile che è open source nelle procedure ma mnemonico nelle attitudini. Danilo Bucchi somiglia solo a Danilo Bucchi: un mix amalgamato che ha definito un proprio archetipo dentro il mare di appartenenze e rimandi.
Punto. Linea. Cerchio… e l’idea comincia a ruotare…