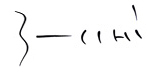2011 – SIGN THE BLACK LINE – MUSEO MLAC – ROMA
Un talento contemporaneo
Domenico Scudero
In Tradition and the Individual Talent (1920) Thomas Stern Eliot scrive che l’apporto individuale non basta a spiegare il talento e che questo si realizza quando condivide il concetto proiettivo di sé in una mondanità estesa, riflessa sulla tradizione. L’interpretazione dominante del talento nella cultura di oggi è pragmatica come lo era nell’America di Eliot e coinvolge l’idea del saper fare qualcosa che abbia una vasta tradizione, ma di saperla fare in modo originale, inusuale, e in qualche modo di stupire per la disinvoltura mondana nella quale si manifesta. Il talento di Danilo Bucchi è probabilmente il tratto dominante del suo profilo artistico, costituito da una severa determinazione nel radicarsi in un universo di segni che rimanda alla tradizione dell’astrazione europea delle prime avanguardie, con l’ausilio di tecniche e supporti fortemente tecnologici. Di fatto si potrebbe dire che l’impatto materico nelle forme astratto-segniche di Danillo Bucchi giunge ad un livello di alterazione smodata, o per l’appunto talentuosa, perché ricostruisce in maniera individuale e assiomatica una modernità diffusa, consolidata e poi resa liquida. Le opere di Bucchi trasmettono questo mondo di segni umanizzati apparentemente facili, ma poi complessi quanto più si osservino. La modernità nella pittura di Bucchi si risolve attraverso un talento contemporaneo che lascia emergere non solo la tradizione dell’avanguardia ma anche una eco mentale, come di pittura ad occhi chiusi, cieca, cara alla sperimentazione pittorica già postmoderna.Osservare i luoghi in cui questa orchestra di segni si ridimensione in una fissità che oltrepassa il ricordo, ha per me il significato inquieto del talento individuale. La domanda su come ciò sia possibile è lo smacco scherzoso che l’artista assesta agli osservatori di superficie.In questo libro, progettato in occasione della mostra di Danilo Bucchi al MLAC, ma il cui contenuto non è concluso nell’analisi esclusiva del ciclo di lavori presentati, la forza dirompente dell’artista emerge continuamente, è direi il motivo scatenante, la frenesia che si riverbera fra le pagine e la grafica del testo. Testi e interviste, note e critica, dal saggio introduttivo di Giorgia Calò all’intervista impossibile di Jérôme Sans, tutto testimonia la febbricitante soluzione creativa di un giovane talento della pittura contemporanea. Un lavoro che non è solo colore e segno ma anche vita vissuta, tecnologie di trasmissione, rapporti spaziali fra studio e galleria, rapporti umani fra individuo, storia e sfera mondana, o sinteticamente, un profilo contemporaneo d’artista.
Segni, ovvero tracce di un percorso insolito
Giorgia Calò
È raro oggi parlare di “pittori” riferendosi all’arte contemporanea. Gli artisti, dal Postmodernismo hanno sperimentato ogni genere di tecnica e mezzo, spesso e volentieri escludendo proprio quello pittorico. Così, a dieci anni dall’entrata nel XXI secolo, l’arte si è fatta sempre più immateriale, tecnologica e spettacolarizzata, all’interno di una società abituata ormai ad usare la comunicazione, con i suoi traumi e i suoi miracoli, come un passepartout buono à tout faire. È questa dunque l’epoca della Postproduzione, come la chiama Bourriaud, in cui prevale la supremazia della cultura dell’appropriazione, l’“Arte Idea”. O per dirla con le parole di Baudrillard, questa è la cultura della simulazione e non della rappresentazione. In questo clima culturale ed artistico può sembrare anacronistico ed obsoleto presentare un “pittore” come Danilo Bucchi, e farlo vedere proprio al MLAC dove, si sa, vengono genericamente predilette le ricerche di cui si è parlato sopra.Di Danilo mi ha colpito la sua onestà intellettuale, il suo modo di dipingere e di riportare su tela idee e sensazioni che partono direttamente dall’inconscio. Osservando e seguendo in particolar modo la genesi dell’ultima produzione di Bucchi, il ciclo dedicato al Segno, si palesa un significato preciso che riassume ed esplica l’intera ricerca dell’artista. Tenendo presente che a partire fin dalle prime opere il Segno è stato sempre attentamente considerato, il soggetto che ne emerge all’interno di una realtà bidimensionale del supporto si fa luogo concreto, per quanto immaginario possa essere. Evitando sfumature o campiture che ne attutirebbero la sferzata, l’artista si concentra sull’immobilità della scena, fissa le posizioni dei personaggi con un atteggiamento stilistico che rinuncia spesso alla prospettiva, li lega attraverso il tratto nero che diviene leggero e libero, svincolato da impedimenti motori di qualsiasi tipo. Negli spazi espositivi del MLAC le pitture di Bucchi si dispongono sulle pareti assumendo la singolare capacità di concentrare su di sé qualsiasi attenzione. Sono carte e dipinti su tela in cui il segno si fa protagonista assoluto, nella ricerca di una sintesi linguistica che rimanda alla più alta tradizione dell’Avanguardia del XX secolo, dall’Action Painting alla Street Art. Sebbene i suoi disegni si possano considerare, come la tradizione vuole, fasi di preparazione a lavori su tela, o comunque più grandi, Bucchi insiste su questa pratica che nasconde in realtà un processo parallelo, dandogli tanta importanza da realizzare con i disegni stessi vere e proprie installazioni. Due parole introduttive vorrei spenderle anche per le sue videoinstallazioni, incentrate sulla sperimentazione tecnica e formale capace di unire fotografia, video e pittura in un solo discorso, tanto da farsi cornice spaziale, hyperframe che invade e penetra l’ambiente circostante, annunciandosi come pittura mediatica in azione.
Il Segno
Generalmente le immagini possono servire come rappresentazioni o come simboli; oppure possono essere usate come puri segni. È difficile dire a quale funzione assolvano le immagini di Danilo Bucchi, poiché se apparentemente si presentano come autentici segni, è pur vero che nascondono sempre diversi significati. I suoi segni si trasformano spesso in una traccia, una scrittura, un percorso. Le linee non temono di scagliarsi contro la superficie, ma anzi sfidano il bianco del supporto, andando a colpirne il pallore con una padronanza riflessiva e pungente, a volte ironica e sarcastica.Nascono così le sue Pagine di Taccuino, pensieri e riflessioni esternati attraverso la parole che si staglia sulla pagina bianca, quella stessa pagina in cui Mallarmé fissava l’essenza pura della poesia, per diventare in questo caso essenza pura dell’immagine. Il Segno resta tuttavia inseparabilmente legato ad un’attenta ricerca formale e stilistica; si costruisce attorno ad un’unica linea essenziale che ne forma la struttura portante, e si palesa attraverso l’azione dell’artista. Bucchi rompe dunque l’equilibrio della superficie bianca mediante i suoi pensieri visivi che diventano Segno e Musica, spartiti metafisici di una melodia immaginaria che si concretizza nel momento in cui il segno riesce ad emettere un suono. È così che la dimensione musicale sembra caratterizzare la riflessione teorica e la pratica pittorica di Danilo Bucchi, che se ne serve come modello cui richiamarsi, nel faticoso processo di definizione di un’arte pittorica totalmente indipendente dal referente naturalistico, o meglio, capace di ritrovare nella specificità dei propri mezzi espressivi nuove possibilità formali.
Il Gesto
Il Gesto di Bucchi è spietato in quanto nasce da modalità espressive di una figurazione creata di getto, all’improvviso, e allo stesso tempo da un processo lento e meticoloso che parte sempre, come i disegni dei bambini, da un cerchio (la testa), al quale le appendici si aggiungono come un flusso continuo. Tutto ciò viene esternato attraverso un disegno rapido, caratterizzato da un tratto dalla linea continua, sicuro e deciso, ma anche molto sintetico, spingendo a volte verso un provocante infantilismo-brutalismo che consente un immediato parallelo con l’opera di Basquiat. Attraverso particolari azioni, che si avvicinano molto all’automatismo inteso come viaggio introspettivo, caratterizzato da un lavoro di memoria e da lunghe sedute di immaginazione, l’artista rappresenta singolari personaggi dalla testa sovradimensionata rispetto al corpo. Sono creature che nascono dal gesto e vengono direttamente spiattellate in faccia allo spettatore, non permettendogli però di leggerne o rintracciarne una storia. Gli sguardi persi nel vuoto, gonfi d’attesa, la malinconia e il senso di solitudine che ne emerge, crea uno stato d’animo che allo stesso tempo attrae e respinge, provoca indifferenza ed empatia, nella visione di queste immagini che sembrano vivere di vita propria attraverso particolari intensità espressive. Sono personaggi apparentemente tutti uguali, divertenti e inoffensivi, simili ai fumetti. In realtà portatori di messaggi disorientanti, tutt’altro che frivoli in quanto esternano la difficoltà esistenziale, l’isolamento dell’uomo nell’incontro/scontro con la società. La figura umana per Bucchi è più che altro una presenza, talvolta un’ombra tra le sfuggenti e distorte prospettive scenografiche, che si anima all’attivarsi di un gioco di sguardi tra soggetto e spettatore. Per questo l’osservatore deve concentrarsi sulle figure, poiché non esiste quasi mai nessun altro elemento narrativo rivelatore che non sia il personaggio stesso all’interno di una ricerca di semplificazione e di traduzione di stati mentali.Dunque velocità compositiva ed essenzialità dinamica delle linee, che permettono a Bucchi di concentrarsi sull’espressione fisionomica, fino alla sua trasformazione in una sorta di caricatura fisica ed emozionale.
La Materia
Dal 2005 Danilo Bucchi comincia ad usare la siringa come estensione del suo braccio. L’artista inserisce dentro questa lo smalto e dipendentemente dall’energia con cui la maneggia, il tratto nero emerge sulla tela ora sottile, ora corposo e materico, sintetizzando così il gesto e la rarefazione del segno che considera il tratto in rapporto alla spazialità. Perché la siringa al posto del pennello? È proprio Bucchi a spiegarcelo quando afferma che secondo lui il pennello è un mezzo di distrazione, nel momento in cui si è costretti a staccarlo dalla tela per reimprimerlo nel colore. E qui il riferimento a Jackson Pollock è quasi scontato, non solo per i mezzi di cui si serve l’artista che, pur essendo un “pittore”, come il maestro dell’Action Painting non usa né il cavalletto, né la tavolozza; ma anche per il fatto di trarre le immagini direttamente dal proprio inconscio. Il suo modo di dipingere è un dialogo veloce tra il proprio mondo interiore e la realtà esteriore. La materia pittorica è attraversata infatti da tratti graffianti e concentrici, caricati dall’immediatezza e dalla velocità con cui vengono eseguiti. Tutto questo è legato a una forte esigenza di ritorno alla pittura, ed è proprio per questo che l’artista dal 2007 comincia ad usare anche la fusaggine, la grafite, l’acquerello, l’olio, il gesso.
Il Colore
Ma è con il colore, anzi con l’assenza o quasi di questo, che si esplica la ricerca artistica di Danilo Bucchi. Scegliere il bianco e nero, solo ed esclusivamente il bianco e nero, con l’aggiunta, a volte, del rosso che tende a mettere in evidenza particolari momenti o simboli, sottolineando un’emozione o un punto focale della rappresentazione. Questa è la scelta di Danilo Bucchi, convinto che i colori dopotutto siano solo superflui suppellettili. E qui mi viene da pensare alla grande disputa cinquecentesca sulla legittimità di assegnare il primato al disegno (Firenze, Michelangelo) oppure al colore (Venezia, Tiziano). Se Bucchi fosse vissuto in quel secolo non ci sarebbero dubbi sulla posizione che avrebbe preso. Fermo restando che è lungi da me paragonare un artista contemporaneo ai grandi maestri del XVI secolo, è però interessante notare come Bucchi metta decisamente al primo posto il disegno rispetto al colore. Questo probabilmente perché il disegno è per Bucchi la scusa migliore per inoltrarsi tra i meandri delle sensazioni e delle sfaccettature comportamentali. Attraverso forme elementari che si distinguono facilmente rispetto alla complessità delle tematiche che raffigurano, Danilo Bucchi ama vedere apparire qualcosa dove prima c’era solo il bianco del supporto. E questo contrasto si può evincere al meglio solo se il disegno è nero. Nero su bianco dunque, come la scrittura, come le pagine di un taccuino.
Lo Spazio Scenico
Nell’ultimo ciclo di opere di Bucchi si compie definitivamente il distacco dallo Spazio reale. Superando il valore terreno, il soggetto perde ogni orpello, ogni riferimento scenografico e temporale, per divenire semplice e nudo simbolo. Immerso in un tempo immobile, lo spazio sospeso afferma la propria corporeità tra il vuoto del bianco e del silenzio, e il pieno delle immagini popolate da dettagli e momenti ovattati; tra primi piani e sfondi scarni. Il linguaggio pittorico di Bucchi slitta dunque continuamente tra il piano razionale e quello psichico.Ma la particolarità che maggiormente sgomenta in questa ricerca, è che più i soggetti rappresentati si staccano dalla terra e da ogni parvenza di umanità, più il segno diventa unico e reale protagonista dello spazio scenico. Le linee forza circolari, assumono una velocità e un dinamismo propulsivo che va al di là del tempo e dello spazio, ma traggono forza e ispirazione direttamente dall’inconscio. Non è un caso che una delle prime mostra personali di Danilo Bucchi, realizzata a Palazzo dei Congressi di Roma nel 2003, abbia come titolo proprio Tratto dall’inconscio. Lo spazio dell’opera si fa dunque spazio aperto, rinviando all’immaginario linguistico e al simbolico che veste l’inconscio. Nel momento stesso in cui questo universo si svela, narrandosi nelle musicali partiture visive, si annulla per farsi pittura, puro significato. Spazio Scenico, dunque, lo spazio di Bucchi, che si accende di segni minimali e pieni di fascino, ponendo con candore questioni sul dissidio tra l’individuo e la società, e percorrendo i labirinti dell’esistenza fatti di silenzi, di “bianchi” attraversati dal pensiero, dall’emozione e dal gesto, o più semplicemente dal Segno.
Nel Segno di Danilo Bucchi
Domenico Scudero
Quando di un uomo si mette in rilievo la sua volontà, s’intende il momento di unità delle sue azioni, e cioè la loro subordinazione alla ragione. (T.W. Adorno, Dialettica Negativa, 1966)
Ragione e volontà sono i parametri logici che interessano tutto il lavoro decennale di Danilo Bucchi, la sua straordinarietà e la sua pervicacia alla ricerca del segno distintivo. Il termine ragione deriva etimologicamente dal latino ratione(m) (da reri, contare, calcolare) e descrive il processo razionale di sviluppo lineare, logico, di un calcolo mentale da cui successivamente il termine ragione nell’accezione duplice, da una parte con significato oggettivante di determinati fenomeni, e dall’altra la facoltà, il raziocinio umano, di cogliere questi fenomeni in sede intelligibile. La volontà è invece la determinazione derivata dal desiderio di raggiungere un preciso obiettivo, in una proiezione futura, termine assunto nel linguaggio filosofico relativamente di recente derivandolo dal latino volùmus che era in uso con funzioni ausiliarie. Ragione e volontà costituiscono nel lavoro di Bucchi la centratura del tempo alla ricerca del segno. La ragione è il passato, la costruzione ontologica, la traccia dell’esistenza sino alla proiezione sensibile della volontà, il futuro manifestato dalla disciplina dell’essere. Il segno di Danilo Bucchi è sostanziamente il tracciato della forza manifestata dall’essere attraverso la sua dialettica interiore fra passato e futuro e disegna il luogo di un presente perpetuo dove si sedimentano esperienza del passato e futuro della sua interpretazione.Ragionando sulle modalità tecniche della forma espressa da Danilo Bucchi ci si ritrova a indagare la tecnica della pittura. Se nelle prime serie di dipinti la pittura era trattata con una buona dose di accademismo, qui compiutamente nel senso tradizionale dei metodi di stesura del colore, la qualità degli ultimi cicli di dipinti manifesta tutta la sua matericità e la sua mancanza di stesura derivata dall’uso di una particolare tecnica. Non so se sia corretto chiamare questo tipo di modalità una vera e propria tecnica pittorica, poiché l’artista ha abbandonato i pennelli e tratta i colori sulla tela con l’ausilio di siringhe. Di tutte le dimensioni, dalle micro siringhe, che lasciano scorrere sottilissimi filamenti di vernice sino a quelle veterinarie, dalla traccia grossa e pastosa.Il significato simbolico della siringa usata come pennello può immediatamente far pensare al versante clinico, farmacologico o addirittura agli stupefacenti, ma allo stesso tempo all’idea di cucina, in particolare ad una cucina dolciaria. Sebbene il primo significato simbolico possa apparire più immediato, poiché un artista impegnato a dipanare il suo particolare punto di vista ossessivo può essere assimilato ad un dopato di segni, nel caso di Bucchi propenderei per l’assonanza con il simbolo culinario d’alta pasticceria. Per intanto constatiamo che il verbo iniettare ha una radice semantica simile a quella di oggetto, provenendo entrambi dal paradigma iectare/iacere che assumeva significato di gettare e lanciare; quindi iniettare è un gettare dentro, mentre l’oggetto è un lanciare contro, pertanto possiamo affermare che già nel gesto iniziale dell’iniettare si costituisce la sostanza dell’oggetto, qui per l’appunto l’oggetto d’arte. Ma tralasciando simili machiavellici orditi semantici posso assicurare che nell’impatto con l’opera reale di Bucchi, in particolare all’interno del suo studio, la mia sensazione iniziale è stata quella di trovarmi al cospetto di un’immensa officina di pasticceria dolciaria. Mi sono quindi concentrato su questa similitudine con qualche perplessità, in primo luogo pensando che potesse essere disdicevole avvicinare il laboratorio di un artista a quello di un sia pur bravo chef pasticcere, tuttavia, alludendo alla questione, mi sono reso conto che l’osservazione non pungolava l’artista, il quale, non posso sbagliare, sorrideva pensoso. La differenza fra l’opera d’arte e il pasticcio zuccheroso consiste essenzialmente nella modalità della funzione. Nessuno mangerebbe mai una pittura di smalti acrilici, tuttavia la percezione mentale della cosa oggettiva, il suo iectare, la sua visibilità complessa, costituisce per il visitatore una similitudine palese con la soffice attrattiva del cibo dolciario. E, d’altra parte, usando una terminologia antropologica il “cotto” socializzato è la base interpretativa attraverso cui Claude Lévi-Strauss indaga il significato della cultura rappresentativa (Il cotto e il crudo, 1964) ipotesi che soprattutto nell’ultimo ventennio ha rappresentato un riferimento teorico molto citato nella critica alla produzione contemporanea. La differenza quindi fra funzione del nutrimento socializzato, che ha implicazioni visive derivate dal mito della natura, e l’arte, consiste esclusivamente nella sua finalità, poiché si potrebbe dire che l’oggetto ha medesime caratteristiche naturali apparenti, fra forma e contenuto oggettivo, e diverse connotazioni fisiche, solo perché il prodotto culinario nutre la visibilità identitaria del mito, e viene ingerito, mentre l’arte assume la totalità del visibile e viene scandita dallo sguardo. In ultimo potremmo dire che l’arte è come un nutrimento visivo e viene ingerito visivamente, ma differentemente dal prodotto culinario non distingue separazioni fra visibilità e invisibilità, poiché al suo cospetto, come nello studio di Bucchi o nei suoi allestimenti complessivi, ci si ritrova immersi in una commestibilità socializzata che si intuisce non digeribile, ma avvolgente l’io e la sua percezione. Se il “pasticcio dolciario” termina nella sua funzione, deperisce in modo repentino o viene consumato, l’opera deperisce con un rilascio molto lento e non può essere assimilata, ma solo ragionata.Se la volontà e la ragione sono le qualità dell’individuo nel raggiungimento di una finalità, l’oggettualità della forma è il fine ultimo nel progetto d’artista. Lavorare sul segno implica però una diversificazione volontaria, sino alla completa realizzazione di una dominante che risulti sconosciuta e personale. Il lavoro di Danilo Bucchi nasce sicuramente da una distorsione, poiché la costruzione di un segno personale è sempre la rottura di un ipotetico coefficiente dominante, direi quello della forma oggettiva ideale. Una forchetta, ad esempio, ha una sua forma riconoscibile ma diventa stile da design quando tende all’equilibrio fra forma e funzione mentre, a dirla con Magritte, non è una forchetta se rimane descritta dalla mimesi della pittura, dalla sua finzione, poiché frutto di una distorsione visiva. Non a caso i pittori surrealisti distorcevano il soggetto perché consapevoli dell’allucinazione della pittura a cui delegavano, finanche nella perfezione della forma, il compito di ingannare lo spettatore, evidenziando non tanto la forma funzione quanto la forma oggetto, distaccata dall’usufruibilità. La storia del XX secolo in arte è certamente una storia di ampliamento dell’azione visibile degli oggetti praticata da soggetti divergenti dall’agire comune. Il mito dell’artista dannato è una complicata commistione della sua visione attraverso l’invisibilità della coscienza individuale delle cose. Lo spirituale kandinskiano, il gemito sconosciuto di Mirò, ma anche l’estraneazione impressionista, prevedono la distorsione non scientifica del soggetto ritratto, tale da generare la riconoscibilità dell’autore. Non credo sia un caso che le prime serie pittoriche di Bucchi abbiano in qualche modo previsto la distorsione come particolare svelato della volontà raziocinante. Una necessità per la realizzazione del segno individuale, la traccia assoluta, lo scarto necessario, che nell’artista contemporaneo enuncia il sapere d’essere consapevolmente nel vivo delle cose. La sua traccia è per l’appunto l’oggetto essenziale, e a questo si sottomettono volontà e ragione, poiché se fosse semplicemente un’azione di potere, la volontà, come sostiene Edgard Wind (Arte e anarchia, 1963) produrrebbe qualcosa di forzoso e artificiale: mentre se la volontà fosse diretta solo alla critica della coscienza condurrebbe ad una costante linguistica da psicanalizzare e non a una forma esclusiva del soggetto pensante (Susan Sontag, Stili di volontà radicale, 1966). La sfocatura e la distorsione nelle prime serie di lavori di Danilo Bucchi registrano la tensione fra reale visibile e reale soggettivo invisibile, l’intreccio ed il chiasma di Merleau-Ponty, l’opposizione al luogo del sentire comune, sostantivato nell’idea del bello massificato: le bambole di Bucchi hanno la bellezza un po’ istupidita delle modelle sulle riviste patinate ma questa bellezza la si riscopre ad uno sguardo attento, metodico, che ripercorre l’esatta verità delle linee smorzate da una pittura slabbrata e sfuocata sullo stile di un’elaborazione digitale in Photoshop.Il segno è dunque il progetto esecutivo, la spettacolarità dell’opera di Bucchi, la sua affermazione volitiva, la sua divinazione. La sua identità si raggiunge con la ragione della storia, la volontà della produzione volta all’interpretazione nel futuro, attraverso un disegno compiuto nell’esattezza del presente con una tecnica volta all’oggettualità, e una disarmonia radicale che identifichi un segno irriproducibile. Non si tratta di una profanazione del bello come descritta da Rosenkrantz, fra amorfia e disarmonia (Estetica del brutto, 1853), bensì di un’ingestione estetica per via di strati pittorici che si allungano dalle viscere della storia moderna, la citata astrazione, il surrealismo, l’informale, l’action painting, il nouveau réalisme, al solo scopo di rappresentare proprio nel segno l’identità di una percezione unitaria. Non a caso nel primo impatto con il lavoro di Bucchi ho pensato a una qualche sintonia con l’astrazione morfologica di Arshile Gorky, uno dei maestri di Jackson Pollock e della liquidità pittorica americana.A questo punto ci si può domandare di quale ipermodernità trattano oggi quegli artisti che elaborano un percorso così denso di rimandi storico critici attraverso il segno, se la percezione ipermoderna fluttua fra la caosmosi di Guattari, la vita liquida di Bauman, il vuoto di Lipovetsky? Cosa c’entra la pittura in tutto ciò? A mio avviso c’è nella consapevolezza degli artisti contemporanei la ricerca di una globalità del sentire. Un senso legittimo della rappresentazione generale, come sosteneva Husserl (Ricerche logiche, 1900) che sfocia nella spettacolarizzazione orchestrata, come lo sono le performance pittoriche musicali di Bucchi, e che vivono proprio nella distorsione della spettacolarità del mondo, falsificandolo. Non è infatti una scena della pittura, non si tratta di un teatro del segno, e non siamo di fronte ad una commedia del disegno, su una pedana illuminata. Si tratta invece di determinare attraverso gli spessori della pittura una vasta superficie che investa la sensibilità dello spettatore e lo ritragga a sé. Nel caso di Danilo Bucchi l’incisione di una volontà nel tempo si trasforma in struttura dell’ulteriore, da graffio sulla superficie a fluido iniettato sulla tela e alle successive tele, sovrapposte alla pelle dell’ambiente sino a ricostruirlo freneticamente. E in fondo una forte, sostanziale differenza, fra ciò che è stato il segno nella recente storia della modernità e ciò che è oggi, consiste proprio nella sua diversificazione dall’oggetto del minuscolo sentire, dal segreto emozionale dell’essere. L’arte contemporanea oggi propone comunque una rappresentazione scenografica del mondo che non teme alcun nascondimento e che riplasma la visione come se la sua azione fosse titanicamente l’unico altro luogo possibile. L’inattualità di una tecnica con l’ipermodenità telematica svanisce così non appena l’azione artistica si produce nella sua vasta complessità, la sua dirompente straordinarietà al cospetto del tempo, la sua inusualità appetibile, la sua commestibilità visiva.