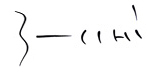2017 – Lunar Black – MACRO – Roma
La macchina del desiderio
L’arte non è che il linguaggio dell’arte. L’immagine è soltanto il desiderio dell’arte di debordare da se stessa e di trasferirsi nell’altrove. L’altrove è il mondo, inteso come luogo e mondo della vita. Quando l’arte abbandona la patetica speranza di essere l’ombra e il doppio della realtà, finalmente esce dalle sue metafore ed entra nel luogo cinico e splendente della metonimia. Essa corrisponde alla coscienza che l’arte acquista di poter vivere accostata ai propri segni, cioè alla consapevolezza dell’autoriferimento. Con la metafora l’arte dispone e consuma ogni sua energia nel captare i segni della realtà per reintrodurli nel proprio spazio, con la metonimia invece essa rivolge e concentra tale energia all’interno della propria soglia, accettando come unico riferimento la presenza del linguaggio. Così, ad un atteggiamento fondamentalmente sintetico, teso a organizzare il linguaggio ad immagine e somiglianza del mondo, subentra un atteggiamento anche analitico, che rivolge la propria attenzione sulla gestione dei propri strumenti espressivi e sul proprio fare.
In questo modo la metafora, l’uso dell’immagine, nasce dall’illusione della presenza del modo dentro il linguaggio, mentre la metonimia, il sistema di auto riferimento, vive nella consapevolezza dell’assenza e dell’impossibilità del mondo di essere rappresentato dal linguaggio dell’arte. Tale coscienza stoica qualifica gran parte dell’arte contemporanea.
L’opera di Danilo Bucchi agisce anch’essa nell’ambito di questa coscienza. La tattica perseguita è quella dell’azzeramento della dimensione spaziale alla semplice superficie bidimensionale del quadro, nella sua riduzione a corpo liscio e speculare che accoglie ed espelle nello stesso tempo la sostanza pittorica. L’unica materia, infatti, è il colore, perché lo spazio è puro supporto ed occasione per l’estensione del colore. Così se la superficie del quadro indica lo spazio, il colore è direttamente il tempo. Il quadro risulta come luogo di una doppia tensione: massima espansione e massima concentrazione. L’espansione nasce dalla stesura piatta e totale del colore che aderisce vitalisticamente alla superficie, puntando verso i confini del quadro, quasi con forza centrifuga. La concentrazione, invece, è data dalla delimitazione che Bucchi ottiene, ritagliando dallo spazio del quadro uno spazio ancora più interno. Egli infatti, oltre il colore, usa una sorta di disegno, attraverso il quale scandisce lo spazio secondo sequenze che gli restituiscono un ordine e una definizione. L’ordito spaziale diventa lo strumento che evidenzia e rappresenta la dimensione temporale.
Qui il tempo va inteso come intervento progressivo sulla superficie del quadro e come scansione di esso. Inizialmente il quadro, preso come stesura assoluta di colore, si propone come misura ed evidenza del gesto pittorico, semplice prova quantitativa del fare pittura. A questo subentra poi la volontà di definire la presenza tautologica del colore, la vitalità prorompente di un linguaggio che non si accontenta di autorappresentarsi, ma conserva una persistente sensualità, che deriva proprio da quell’altrove (il mondo della vita) che sembra precluso al linguaggio. Perché il linguaggio vive su un proprio sistema di segni che, per sua definizione storica, agisce in un proprio ambito specifico, non quello della vita. E se la vita significa affermazione diretta dell’erotismo, allora il linguaggio dell’arte è lo spazio obliquo, il gesto indiretto, che riflette soltanto se stesso.
La riflessione significa metodo e tensione analitica. Capacità di dare una sistemazione ed un ordine al movimento aperto e diretto della vita. Bucchi, dopo l’affermazione tautologica del proprio fare, del fare pittura, introduce il momento della coscienza obliqua e artificiale di questo fare. Tale coscienza è appunto il momento temporale, geometrico, dell’opera. Un filo sottilissimo, come un riquadro, scorre lungo i bordi e delimita con nuovi confini lo spazio in espansione del quadro. Oppure l’artista costruisce un reticolo, attraverso il quale scandisce secondo quadrati misurati e ripetuti questo stesso spazio. Un altro espediente per bloccare la fuga del colore dentro il linguaggio, dentro la superficie del quadro, è l’introduzione al centro di semplici segni. Tali segni diventano punti di riferimento e di tensione che attirano magneticamente su di sé tutto lo spazio possibile, che è sempre quello del quadro.
Allora i reticoli, le riquadrature, le finestre che si aprono all’interno del quadro, se da una parte producono il congelamento della dimensione spaziale, dall’altro danno una durata letterale e una permanenza, di uno spazio reso segreto dall’improvvisa scansione, dalla presenza quasi maligna della cifra. Quindi la dimensione temporale, documentata come successivo intervento sull’iniziale quantum pittorico, è resa lucidamente sempre in termini di evidenza e concretezza come riaffermazione e delimitazione dello spazio. Bucchi sfugge alla tentazione metafisica di definire il tempo in termini di vuoto e di assenza. Materialisticamente l’artista utilizza soltanto la presenza lampante del linguaggio di cui dispone. Il quadre diventa il pieno esercizio di tutti gli strumenti linguistici di cui dispone il pittore: la superficie, il colore.
L’intenzionale riduzione della pittura alle sue grammatiche, se pure significa la negazione della metafisica e la riaffermazione di un atteggiamento metonimia verso l’arte, dove non ci sono rimandi, ribadisce comunque l’ineluttabile artificialità dell’arte. Altro è invece l’artificiosità della metafora come processo di verosimiglianza, in quanto non cerca il confronto con quello che è il suo termine di paragone naturale, il mondo, ma un proprio funzionamento interno, corrispondente all’ingranaggio linguistico dell’opera. L’opera è una macchina, un apparato delimitato e delimitante di strumenti che tendono a perpetuare un proprio movimento interno.
L’arte, la pittura, diventa una macchina del desiderio che, per la legge di Deleuze e Guattari, ha bisogno proprio del desiderio per potere funzionare, ma senza poter a sua volta produrre alcun desiderio. Questo è soltanto il procedimento attivante l’intenzione e il gesto pittorico. Un desiderio quindi tautologico che riafferma una sorta di persistente biologia dell’arte, un bisogno che muove l’artista al gesto pittorico.
La macchina del desiderio altro è rispetto a quello che costituisce il centro oscuro della vita, l’eros. L’eros porta, nella sua accezione freudiana, all’espansione e alla perpetuazione dentro la vita. Nel significato platonico, invece, riacquista quei connotati di ricerca all’interno ed un movimento alla concentrazione e alla riduzione. La pittura è la macchina che produce tale concentrazione e tale riduzione. Le dimensioni plurime della vita vengono ridotte ad una sola, a quella di un linguaggio che riesce ad organizzarsi ed a muoversi soltanto nella dimensione spaziale. Nella pittura di Bucchi la macchina è bene evidente nella splendente presenza delle sue superfici bidimensionali. Forse, a sua insaputa, ad insaputa dell’artista, la pittura non si lascia scardinare dalla propria consistenza di macchina del desiderio. Forse da questo nasce il continuo assalto di Bucchi al sistema della pittura.
Bucchi lubrifica ed addolcisce la macchina irriducibile mediante colori stemperati in maniera distesa sulla superficie del quadro. Gli sgocciolii sono proprio le prove, i segni del suo gesto pittorico, di chi lascia una traccia soggettiva su di un ingranaggio oggettivo. Il desiderio dunque è semplicemente quello del movimento che approda alla pittura, la quale, come una superficie speculare, riflette e rimuove da sé tutto quello che l’artista vuole portarvi dentro, ma che non le è connaturato e specifico: la vita e i suoi detriti.
Parlare di sensualità, nel caso di Bucchi, significa ribadire la coazione, accettata spontaneamente di tornare a stare nella pittura, che resta lo spazio ridotto e concentrato della bidimensione. L’apparente neutralità del funzionamento oggettivo della macchina non significa né l’immobilità né la cancellazione delle contraddizioni: metafora contro metonimia, espansione contro cancellazione, gesto dell’artista contro lo spazio del quadro. Finalmente l’artista contemporaneo non ricerca più nell’arte un prolungamento epico del proprio essere, ma vive la contraddizione come spazio della propria esistenza. Bucchi non dà al suo gesto pittorico una teleologia, che potrebbe essere quella di frantumare la macchina pittorica, bensì riafferma attraverso il proprio fare l’irriducibilità di una doppia presenza: l’Io e il linguaggio.
Il linguaggio non è la metafora consolatoria della vita, è un luogo circoscritto in cui avviene una lotta specifica ed un movimento che riporta tale lotta specifica ed un movimento che riporta tale lotta semplicemente al confronto tra due posizioni: espansione della vita e concentrazione dell’arte, eros affermativo del movimento aperto ed eros affermativo di un movimento chiuso e ridotto. In questo senso la pittura di Bucchi è sensuale, felice, senza sensi di colpa, ma per questo anche raffreddata, infelice, segno evidente di impossibilità. L’impossibilità è anche la totale possibilità, in quanto circoscritta a un luogo, la tela, in cui nulla è e dove, paradossalmente, tutto è in atto. L’atto è la presenza fenomenica del quadro ricoperto di colore, delimitato nella sua entità spaziale e segnato ulteriormente da linee che lo definiscono temporalmente. Nulla può intaccare le parete liscia della macchina del desiderio, della pittura.
Nulla può scalfire l’ineluttabile bidimensionalità della pittura, ed anche i fogli aderiscono, come veline senza spessore, sulla piatta consistenza del quadro. Spesso il foglio prova ad ingabbiarsi, a creare dei sottili spessori di spazio, come delle venature. Ma lo spazio definitivo, quello ultimo ed ultimato, riesce ad assorbire queste nuove circostanze spaziali. Anzi, queste, con la loro presenza, ribadiscono l’impossibilità di scalfire la bidimensionalità della macchina pittorica, perché la bidimensionalità è proprio il connotato dell’artificialità e della sua essenza di macchina.
La qualità delle immagini citate non ha mai sconfitto, né mai trasgredito la soglia del quadro disposta con una sua dura frontalità. La negazione dello spazio, attraverso la frontalità, significa la riaffermazione dell’assenza del tempo, un rimanere dentro la persistente apparenza, come visibile, dei segni, un ribadire la concretezza della pittura. La macchina del desiderio produce ancora una volta lo spettacolo della pittura, inteso come esibizione frontale di segni che abitano soltanto il proprio spazio interno, dove si condensano e nello stesso tempo si sciolgono.
Ancora una volta Bucchi ha controllato il mezzo linguistico e lo ha riportato alla coscienza metonimica dell’arte. Perché la metonimia è finalmente coscienza dell’irriducibilità del gesto artistico e dell’inevitabile speculari del linguaggio. La macchina del desiderio è dunque una macchina intelligente che prevede e neutralizza qualsiasi utopia e tentativo metafisico di rimandare all’altrove, al di fuori del proprio congegno, di riportare ogni intenzione al di qua del proprio funzionamento.
Il segno di Bucchi non vola svincolato nella nerità della materia, egli non vuole trasformare l’arte in una pratica che cancella la gravità fisica del mondo nella leggerezza di un personale delirio di onnipotenza. In un segno arbitrario fondato su un puro atto potenziale del sogno, che toglie completezza all’immaginazione. Bucchi vuole potenziarlo mediante la fondazione di un metodo reale, figurabile, capace di estrarre un segno, formalizzando e circoscrivendo nel recinto di una forma necessaria l’oscuro peso del colore. L’arma dell’artista è il linguaggio, un apparato di strumenti che lo pongono nella condizione di reagire realmente, in maniera concreta e visibile, infallibile e nello stesso tempo temeraria.
Bucchi ha avuto l’intelligenza creativa di rispettare la meccanica della macchina e di assecondarla mediante l’uso di una sensibilità avvolgente ed il rispetto della sua immanenza. L’immanenza consiste nel suo darsi soltanto come strumento che afferma la spazialità, come unica dimensione e come dimensione che cancella il tempo, che è ancora il tentativo dell’artista di usare il linguaggio come doppio della realtà.
Achille Bonito Oliva