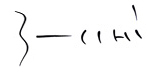2014 – MONOCHROME – Galleria Poggiali – Firenze
DIARIO DI UNA VISITA NELLO STUDIO DI DANILO BUCCHI
di Angela Madesani
Un giorno di agosto del 2014, stranamente caldo1, ero seduta sul divano dello studio di Danilo Bucchi a Roma. Un luogo pieno di stimoli, di punti di vista, di oggetti affascinanti: carte, siringhe2, macchine fotografiche3, obiettivi, ordinatamente raccolti in un piccolo armadio a vetri, posto sul tavolo di fianco al computer. Si parlava di arte, di pittura, si guardavano le opere, quando, a un certo punto, la coda del mio occhio curioso, si è posata su un quadro di medie dimensioni, che sta di fianco al divano, in una posizione non eccessivamente visibile. Sono rimasta colpita dalla sua economia spaziale. Si tratta di un quadro bianco in cui nell’angolo sinistro è una zona dipinta di nero, popolata dai suoi soliti personaggi. È un’opera alla quale Bucchi è particolarmente legato. È una sorta di manifesto pittorico. Vi ho percepito, mutatis mutandis, un rimando a un famoso dipinto di Jacques Louis David4, La morte di Marat, del 1793, in cui il soggetto del dipinto è nella zona bassa della tela e ne occupa circa la metà. Il resto è costituito da un’ampia zona monocroma scura.
Il richiamo è dovuto al fatto che il soggetto di entrambe le opere è la pittura nella sua essenza più profonda. E il cammino di Bucchi nell’arte inizia proprio per amore della pittura. Da ragazzo, va con il padre a trovare Mario Schifano nel suo studio, in via delle Mantellate e lì rimane colpito dalla sintesi stilistica, dalla libertà pittorica dell’artista. Capisce così che ha ancora senso dedicarvisi. Percepisce, con la forza e l’inesperienza di un adolescente, l’amore e la passione che possono muovere un artista. Dopo poco si iscrive al Liceo artistico e quindi all’Accademia di Roma, dove studia, appunto, Pittura.
In tutte le opere di Danilo Bucchi il peso del vuoto è determinante. Lui stesso spiega che, in tal senso, è importante la sua autobiografia: «Sono romano, profondamente legato alla mia città. Roma è una bella, vecchia signora piena di gioielli. È quasi impossibile riuscire ad aggiungere qualcosa. Penso, anzi, sia più importante levare»5. Nato alla fine degli anni Settanta, nel 1978, si è formato con la Graffiti Art, che è riuscito a metabolizzare e a digerire, dando vita a un linguaggio proprio, facilmente riconoscibile, che con quel tipo di arte ha, però, ben pochi legami. All’artista romano interessa semplificare. Le sue opere più note, più riconoscibili sono costituite da linee nere che vanno a costruire figure, pupazzi stilizzati, piccole case e segni. Per farlo utilizza una siringa, come già detto, dotata di aghi più o meno sottili. È come una sorta di scrittura, che ha come punto di partenza l’utilizzo ricorrente, quotidiano di taccuini, sui quali l’artista disegna: «Il disegno, la pittura hanno sostituito, per me, la scrittura. Mi viene naturale esprimermi attraverso un flusso di inchiostro, che corre sul foglio come se fosse una grafia. Per me è come una sorta di sana ossessione compulsiva»6. In un testo di qualche anno fa Giorgia Calò scriveva: «Il Segno resta tuttavia inseparabilmente legato ad un’attenta ricerca formale e stilistica; si costruisce attorno ad un’ unica linea essenziale che ne forma la struttura portante, e si palesa attraverso l’azione dell’artista»7.
Ma qui cominciano i problemi: la tela è costituita da trama e ordito e raramente la tessitura è così fitta da avere la stessa valenza della carta, materiale amatissimo e assai utilizzato. Così Bucchi prepara le tele rendendole bianche8, di un bianco impenetrabile in cui lo smalto non riesce a penetrare nella trama della tela, provocando fastidiose sbavature. In fondo, parafrasando Lucio Fontana, l’azione della pittura è una sorta di battaglia con la tela bianca. Il pensiero spaziale, il desiderio di costruzione è evidente, in tutte le opere di Danilo Bucchi. La sua è una vera e propria ossessione per la precisione del segno a volte leggero, a volte più pesante. In taluni punti pare, persino, di percepire un senso di tridimensionalità. Il bianco di fondo è una necessità di purezza, come un azzeramento dal quale ripartire ogni volta per riuscire ad andare avanti. In tutto questo è un continuo gioco di livelli che si sovrappongono. Chi guarda può avere un ruolo attivo nel suo lavoro, lo spazio bianco lascia la possibilità di intervenire con lo sguardo, attribuendo a esso una potenzialità costruttiva. Il suo segno è un elemento primario dell’alfabeto pittorico, che si espone nella sua nudità. È come uno scheletro che attende di essere coperto dalla carne.
È come un esercizio liberatorio, di purificazione, un mantra che riesce a farlo stare bene con se stesso e con il mondo. I suoi segni, appunto, possono essere combinati all’infinito. La difficoltà è quella di riuscire a fermarsi. Per la maggior parte dei lavori Bucchi usa dei non colori: il bianco e il nero, ai quali, di rado, si affianca il rosso drammatico e difficile nella sua apparenza preponderante, un colore che è profondamente radicato nel suo essere pittore. Del resto il rosso, a sua detta, è il colore più sensuale che ci sia e le Combustioni rosse di Burri sono una delle opere più erotiche della storia dell’arte, per le quali l’artista prova una particolare attrazione. Nulla è dato mai per scontato. Nei confronti di ogni nuovo quadro il suo è un atteggiamento misto di entusiasmo e di angoscia. Non si tratta mai di mestiere: quello di Bucchi è, piuttosto, un bisogno prepotente di risolvere le diverse problematiche spaziali, strutturali che si vengono a creare, dando vita a un mondo di figure, formalmente vicine tra loro, che funzionano come unità di misura da cui partire per creare dele situazioni. In ognuna delle sue opere è come se si percepisse una musicalità più o meno intensa. Bucchi ama tutta la buona musica, in particolare quella elettronica, che offre un bit non saturo, che lascia spazio di intervento a chi ascolta, proprio come le sue opere. «La verità dei bianchi e la verità dei neri con una giusta equazione offrono una possibile chiave di accesso»9. Nella mostra fiorentina saranno anche alcuni grandi dipinti con le bambole.
Sul fondo bianco campeggia in ognuno di loro una bambola, spesso in posizione seduta. Si tratta di un ciclo10 che ha preso il via nel 2005 e che si è esaurito nel 2012. Inizialmente si è trattato di un esercizio di stile, poi il tutto ha assunto una connotazione precisa. Il rapporto con l’olio, con la sua matericità quasi scultorea, è diventato una vera e propria esigenza poetica. Le figure andavano a coprire gli scheletri, formati dal segno. In esse pare di trovare dei legami con certe espressioni artistiche degli anni Venti e Trenta, con la dadaista Hannah Höch. Ma il riferimento non è preciso, non ci sono citazioni, si tratta piuttosto della metabolizzazione di quanto ha visto e continua a vedere, di quello che ha studiato con interesse nel corso degli anni. «Tutti siamo paragonabili a qualcuno, solo nel segno e nella grafia si trova l’autenticità»11.
Le bambole richiamano figure femminili, sono ritratti psicologici, figure pescate nell’inconscio che nascono dall’interiorità e che trovano una forma esterna in una sorta di contaminazione fra le diverse parti dell’esistenza, in cui mi pare di poter leggere anche una profonda malinconia, la malinconia saturnina degli artisti, ma anche quella più naturale dello scorrere ineluttabile del tempo. Le bambole nascono da un’operazione di scavo nella memoria, di ripresa di dettagli di volti femminili. I titoli non sono una scelta iniziale proprio come lo sviluppo dei singoli quadri. Il suo non è un operare per giungere a un preciso scopo. È il quadro che gli si manifesta nel suo farsi e di conseguenza nascono i titoli. L’atteggiamento di Bucchi nei confronti dell’arte non è di dominio, è, piuttosto, la volontà di lasciarsi andare per farsi condurre in territori ancora da scoprire, attraverso i quali è possibile svelare il senso delle cose a lui e a noi che guardiamo.
1 L’estate del 2014 ha offerto in Italia ben poche giornate calde.
2 «Perché la siringa al posto del pennello? È proprio Bucchi a spiegarcelo quando afferma che secondo lui il pennello è un mezzo di distrazione, nel momento in cui si è costretti a staccarlo dalla tela per reimprimerlo nel colore» in G.Calò, Segni, ovvero tracce di un percorso insolito in D.Scudero, G.Calò, Danilo Bucchi Signs. The Black Line, Gangemi Editore, Roma, 2011; p.24.
3 Bucchi non gira mai senza la sua macchina fotografica, attraverso la quale prende appunti di quanto lo circonda.
4 J.L.David (1748-1825) è stato un pittore francese, che, avendo vinto il Prix de Rome, nel 1775, raggiunge l’Italia dove resta per cinque anni e dove scopre l’arte del nostro paese, in particolare Michelangelo, Raffaello, Caravaggio, Guido Reni e dove, si avvicina, soprattutto da un punto di vista teorico, al Neoclassicismo, nel 1780 fa ritorno in patria.
5 Danilo Bucchi, durante una conversazione con chi scrive, agosto 2014.
6 Danilo Bucchi, durante una conversazione con chi scrive, agosto 2014.
7 G.Calò, op.cit.; p. 22.
8 Ha compiuto lunghe ricerche di materiali per riuscire a compiere questa operazione in maniera soddisfacente.
9 Danilo Bucchi, durante una conversazione con chi scrive, agosto 2014.
10 Bucchi lavora per cicli di lavori.
11 Danilo Bucchi, durante una conversazione con chi scrive, agosto 2014.